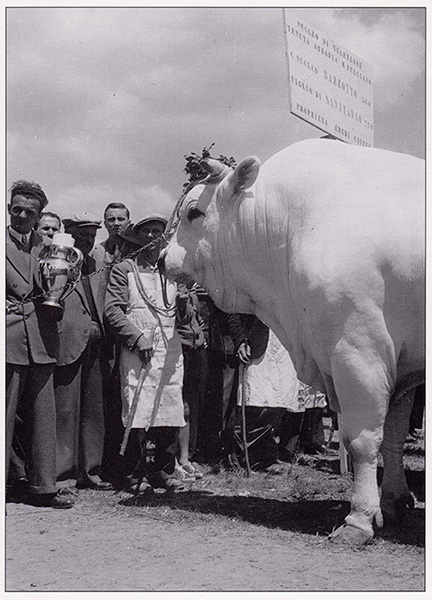| |
Cenni storico-geografici della Valdichiana.
--Tratto
da: La Razza Bovina di Val di Chiana--
di M. Piccinini - C Gugnoni - a cura di Mario Morellini
Se la conoscenza
storico-geografica dell'ambiente ove una razza d'animali vive e dove à
avuto origine è necessaria per la conoscenza esatta della razza
medesima, indispensabile ci è il conoscere geograficamente e
storicamente la Valdichiana, poiché poche razze di animali anno le
proprie vicende, il proprio cammino tanto intimamente connesso con le
vicende della terra loro culla di origine, come quella bovina di
Valdichiana le à con la valle che ne fu la culla e che ne è attualmente
il centro di diffusione. È perciò che nel nostro assunto, non possiamo
esimerci dal descrivere sommariamente le vicende storiche, le condizioni
geografiche, le mutazioni idrologiche dell'ambiente ove la razza è nata,
ove tuttora vive.
Il Fossombroni scriveva:
«La pianura di Valdichiana è un tratto di campagna serrato fra due
catene di montuosità le quali si distendono pressoché parallelamente al
Mediterraneo avendo all'australe estremità il fiume Paglia, e l'Arno
alla boreale, la sua lunghezza è circa sessanta miglia......
Attualmente col nome di Valdichiana si chiama soltanto una parte della
vallata dal Fossombroni descritta; limitata a Nord dalla Goletta di
Chiani ed a Sud da Città della Pieve e Chiusi; designandosi col nome di
Chianetta Romana il rimanente australe e con quelli di Pian d'Arezzo e
Pian di Quarata la parte boreale, dalla stretta di Chiani all'Arno.
Così limitata viene a
comprendere tutto il bacino orografico della Chiana eccezion fatta della
parte prossima alla sua confluenza con l'Arno e cioè le valli del
Vingone e del Castro; l'alto bacino della Chiana è nettamente separato
dal basso dal Monte Lagnano e dalle colline di Quarto, Santa Fiora e
Chiani, presso cui esiste la così detta Goletta di Chiani che permette
il passo alle acque del Canale.
La Valdichiana comincia adunque all'Argine di Separazione, rialzo
artificiale di terra (alto m. 1,60 circa, largo m. 2,20) che divide le
acque defluenti all'Arno da quelle defluenti al Tevere, situato poco al
Nord della stazione ferroviaria di Chiusi ed appoggiato alle ultime
pendici delle colline di Chiusi e Città della Pieve.
Poco a Nord dell'argine trovasi il lago di Chiusi, nel quale si gettano
il torrente Presa ed il fosso di Montelungo; dall'estremo nord di questo
lago si parte un canale arginato, chiamato Passo alla Querce, che si
scarica nel lago di Montepulciano, più piccolo del precedente, ed in
continua diminuzione di estensione per le colmate che vi effettuano i
torrenti Parco e Salchetto a questo scopo immessivi.
Da questo secondo lago si
origina il Canale Maestro della Chiana che, in tronchi rettilinei e bene
arginati, percorre la valle in tutta la sua lunghezza. Affluiscono alla
Chiana, o direttamente o per mezzo dei così detti allacciami scavati
alla destra ed alla sinistra del Canale allo scopo di evitarne i
possibili interramenti, i torrenti Salarco, Foenna ingrossato dal
Galegno, Esse di Marciano ingrossato dal Leprone, ed il Lota alla,
sinistra; Chianacce, Esse di Cortona ingrossato dalla Mucchia, con le
acque della Caprara, Fosso di Montecchio che reca le acque del Lega, del
Citone, del Vingone e Loreto, Cozzano a destra; e dopo la Goletta di
Chiani, il Vingone ed il Castro.
L'aspetto generale della
Valdichiana è quello di una vasta pianura orizzontale, limitata da
colline ubertosissime eccezion fatta da Cortona ai pressi di Arezzo nel
qual tratto è limitata da monti aspri e brulli. Essa si estende nei
territori dei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Civitella della
Chiana, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano e Monte S. Savino della
provincia di Arezzo; in quelli di Abbadia, Bettolle, Cetona, Chianciano,
Chiusi, Montepulciano, Sarteano e Torrita e della provincia di Siena; in
quello di Castiglion del Lago, Città della Pieve della provincia di
Perugia,
La lunghezza della valle è di circa km. 57, la larghezza di km. 20
circa.
Una fìtta rete di ottime strade provinciali, comunali e vicinali rende
ottima la viabilità nella valle, facili le comunicazioni fra paesi e
villaggi.
Due strade ferrate la
percorrono, non centralmente però, l'una è la linea Empoli-Siena-Chiusi
che passa in Valdichiana per le stazioni di Lucignano, Sinalunga,
Torrita, Montepulciano, Chianciano; l'altra la linea Firenze-Roma, che
passa per le stazioni di Frassineto, Castiglion Fiorentino, Cortona e
Chiusi.
Nella descrizione geologica
della Valdichiana, bisogna esaminare due parti ben distinte: quella dei
monti e quella dei collie pianura. Nella prima zona appaiono scoperte le
roccie d'emersione antica, precedenti il pliocene e forse anche il
miocene; nei monti che limitano a destra la valle predominano gli strati
d'arenaria schistosa unita a schisto marnoso ed a poco alberese; quelli
di sinistra sono costituiti principalmente da varie modificazioni
dell'arenaria macigno. Il detrito di queste roccie forma il terreno
vegetabile e quello di alluvione delle piccole valli inferiori, colline
e piaggie.
Il terreno alluvionale della
zona di pianura rimonta in parte all'epoca antidiluviana, come attestano
le crete tufacee ricche di conchiglie. Il terreno alluvionale è però in
gran parte coperto da uno spesso strato di terreno di colmazione dovuto
alle numerose bonifiche idrauliche.
La configurazione della valle
non fu sempre l'attuale, essa anzi ci offre un esempi provato con dati
storici indiscutibili, di un ramo di un sistema fluviale che, per cause
naturali ed artificiali, cessa di tributare al suo antico fiume, Tevere,
per rivolgersi ad un altro, Arno.
I golfi, Etrusco e Latino, del mare pliocenico, pur addentrandosi dove
ora sono basse valli dell'Arno e del Tevere non occupavano il bacino di
Firenze nè quelli di Arezzo e Valdarno che dovevano essere vaste conche
lacustri.
Il lago di Valdarno doveva
tributare, per un emissario lungo la valle d'Ambra, col mare.
Per il grande sollevamento pliocenico e quaternario, sollevamento più
forte, nel zona tirrenica, nel Preappennino che nell'Appennino, le acque
dovettero raccogliersi contro quest'ultimo.
Tutto l'attuale Pian d'Arezzo
e Valdichiana dovette essere un vasto Iago estendendosi fino al bacino
dell'attuale Trasimeno dapprima, poi da questo separato. Il lago del
Valdarno dovè cessare di tributare le sue acque al mare per la Val
d'Ambra, ma le dovè mandare unite a quelle del Casentino verso Arezzo.
Poscia per l'approfondimento delle gole della Gonfolina ed Incisa, non
stiamo ora ad indagare se avvenuto esclusivamente per l'erosione delle
acque o se coadiuvato da colossale e magistrale opera umana, le due
conche lacustri di Firenze e Valdarno si congiunsero, il letto fluviale
si approfondì, le acque del Casentino furono ad esso richiamate e si
ebbe il
"...fiumicel,
che nasce in Falterona,
E
cento miglia di corso nol sazia"
Il lago
di Arezzo e Valdichiana, per non ricever più le acque del Casentino,
andava restringendo la sua conca sin che nel periodo storico troviamo la
Valdichiana non più lago o palude, ma campagna emersa, attraversata dal
fiume Clanis che aveva origine presso Arezzo e mandava le sue
acque al Tevere.
Non
possiamo qui discutere se già nel periodo Terziario l'uomo abitasse la
Valdichiana o se, come i più vogliono, soltanto nel Diluvium
"...il nobil selvaggio errava rozzo nelle fitte foreste."
nè se
prima dell'uomo, uomo, siano vissuti nella valle tributaria del Tevere e
dell'Arno animali antropoidi.
Ciò
esorbita troppo dal nostro compito, nè tali indagini potrebbero portare
luce alcuna sull'origini della razza bovina, oggetto del nostro studio.
Per
quanto nelle vicinanze di Brolio, nello scavare il letto della Chiana,
si siano trovate delle palafitte, che, secondo il Gamurrini, reggevano
un tempio etrusco emergente dalle acque, è pur certo che i primi
abitatori della Italia centrale non son vissuti in abitazioni palustri,
in vere e proprie palafitte. E la mancanza di queste abitazioni è di
grave ostacolo alla conoscenza connessa della preistoria della nostra
Italia.
Là dove i
popoli primitivi vivevano in villaggi costruiti su palafitte, si à una
pagina eloquente di preistoria, che squarcia le tenebre che regnano
ancora invulnerate o quasi là dove ben pochi o punti si son trovati gli
avanzi delle abitazioni primitive.
Dove le
palafitte furono è possibile avere indizi certi, traccie
meravigliosamente ordinate dei progressi della civiltà; è possibile
seguire le conquiste dell' uomo fatte fin dal primo periodo del
neolitico, quando non aveva, coadiuvatori nella lotta per l'esistenza,
che strumenti di pietra, fino alla piena età del ferro.
I resti
delle palafitte ci dicono della più grande conquista dell' uomo, la
domesticazione degli animali, ci dicono quali furono le prime specie
asservite, quali ne erano le caratteristiche. Dove le palafitte mancano
tutto tace, nessun indizio può guidare in queste importantissime
ricerche.
Ben poco sappiamo dei
Tirreni, degli Umbri, dei Tusci, degli Oschi che si vuole essere stati i
primi abitatori delle nostre terre; poco o nulla conosciamo della loro
civiltà, delle loro origini ; dobbiamo però fermamente ritenere che
dall'Asia emigrarono i nostri padri e che quindi ben a ragione Seneca
diceva: che dall'Asia a sè rivendica i toscani : Tuscos Asia sibi
vindicat.
Meno fitte ed impenetrabili si fanno le tenebre nell' ultima epoca
Etrusca, poiché qualcosa ne ànno scritto i Romani ed eloquentemente ne
parla l'archeologia.
Non sappiamo l'origine degli etruschi, nè se derivarono da una sola o
dalla fusione di più razze; ma sappiamo che più di trenta secoli fa si
formò nella media Italia questo nuovo popolo; popolo operoso, civile,
fiorente, cultore dell' agricoltura, della pastorizia, dell' arti belle.
|
|